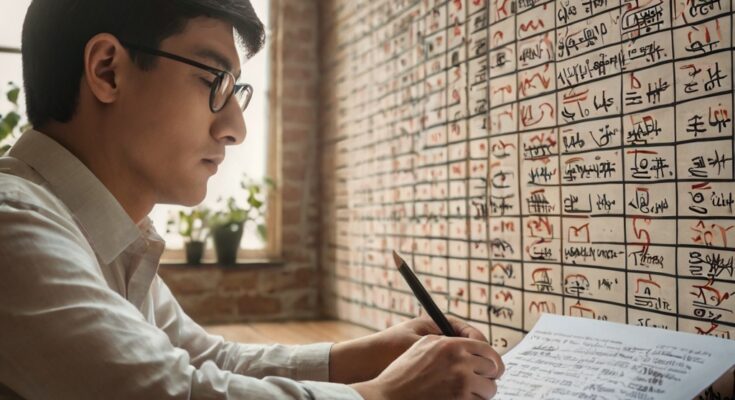L’articolo riporta la storia della definizione di intelligenza.
Ma cosa è l’intelligenza?
In ambito scientifico, la concezione di intelligenza si è evoluta notevolmente nel tempo. Snyderman e Rothman (1987) cercarono di arrivare a una definizione precisa, consultando un gruppo di scienziati: alcuni vedevano l’intelligenza come capacità cognitive superiori (ragionamento, problem solving), altri invece come l’insieme delle abilità necessarie per un miglior adattamento all’ambiente.
Un po’ di storia
Francis Galton (1885) considerava l’intelligenza come una proprietà ereditaria del sistema nervoso, basata sulla rapidità della trasmissione nervosa. Tuttavia, i suoi esperimenti sulla velocità di reazione e sull’acuità sensoriale erano troppo semplici per fornire una misura adeguata dell’intelligenza.
Alfred Binet sviluppò il primo test di intelligenza su incarico del Ministero della Pubblica Istruzione francese per determinare il livello scolastico adatto ai bambini. La scala di Binet e Simon introdusse il concetto di età mentale (EM). La Stanford-Binet, una versione successiva, introdusse il Quoziente di Intelligenza (QI), ideato da Stern.
Charles Spearman (1923) sviluppò una teoria mono-fattoriale dell’intelligenza, identificando un unico “fattore G” (intelligenza generale) che può essere misurato con test di logica.
Raymond Cattell (1943, 1971) ampliò la teoria di Spearman, distinguendo tra intelligenza fluida (GF) e intelligenza cristallizzata (GC). L’intelligenza fluida riguarda la capacità di risolvere problemi nuovi, mentre l’intelligenza cristallizzata si basa su conoscenze ed esperienze passate.
Howard Gardner e le intelligenze multiple
Howard Gardner propose la teoria delle intelligenze multiple, secondo cui l’intelligenza non è unitaria ma composta da diverse dimensioni autonome. Gardner inizialmente identificò sette intelligenze e successivamente ne aggiunse un’ottava:
- Linguistica: Uso efficace del linguaggio.
- Logico-matematica: Ragionamento logico e problem solving.
- Spaziale: Percezione e manipolazione di forme e spazi.
- Corporeo-cinestetica: Uso del corpo per esprimersi e risolvere problemi.
- Musicale: Riconoscere, creare e riprodurre ritmi e melodie.
- Interpersonale: Comprendere e interagire con gli altri.
- Intrapersonale: Comprendere se stessi e regolare la propria vita.
- Naturalistica: Riconoscere e classificare elementi dell’ambiente naturale.
Robert Sternberg e la teoria triarchica dell’intelligenza
Robert Sternberg sviluppò la teoria triarchica dell’intelligenza, che ne identifica tre componenti principali:
- Intelligenza analitica: Capacità di analizzare, valutare e comparare.
- Intelligenza creativa: Capacità di inventare, scoprire e immaginare soluzioni nuove.
- Intelligenza pratica: Capacità di applicare conoscenze e abilità a situazioni reali.
Sternberg enfatizza che l’intelligenza coinvolge diverse componenti mentali:
- Metacomponenti: Processi esecutivi che decidono cosa fare e come farlo.
- Componenti di performance: Processi coinvolti nell’esecuzione di un compito.
- Componenti di acquisizione di conoscenza: Processi utilizzati nell’apprendimento e nel coordinamento delle azioni.
Le differenze di prestazione nei test di intelligenza sono correlate alle strategie di problem solving adottate. Studi neurofisiologici, come quelli di Duncan et al. (2000), mostrano che compiti che misurano l’intelligenza fluida attivano i lobi frontali, confermando l’importanza delle metacomponenti.
Conclusione
La concezione di intelligenza ha visto diverse evoluzioni, passando da una visione mono-fattoriale a una più complessa e articolata. Gardner ha ampliato il concetto introducendo le intelligenze multiple, mentre Sternberg ha proposto una visione triarchica, mettendo in luce l’importanza di componenti analitiche, creative e pratiche.